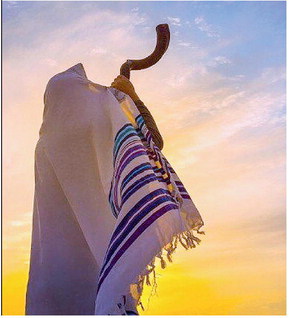Così la Bibbia insegna il giusto valore di un bene economico (oltre l’equità)
CARLO
BELLAVITE PELLEGRINI
L’Antico Testamento fornisce una guida che resta valida anche oggi: nessuno deve fare torto al proprio fratello
Nel Levitico si parla di come calcolare il prezzo di un campo. Nel contesto del Giubileo la terra doveva tornare al proprietario iniziale, perché la terra è di Dio e l’uomo solo amministratore
«Come facciamo a determinare il valore corrente di un’attività reale o finanziaria?». Questa domanda costituisce la base di un corso introduttivo di finanza aziendale in una qualsiasi facoltà di scienze economiche e finanziarie. Ho rivolto spesso questa domanda ai miei studenti del corso di Finanza Aziendale presso l’Università Cattolica di Milano. E, destando in loro grande interesse e curiosità, ho aggiunto che avremmo cercato la risposta a questa domanda nell’Antico Testamento e, più precisamente, in Levitico 25, 14-16. Questa interpretazione rappresenta concretamente quella “fusione di orizzonti” proposta da Gadamer in prospettiva ermeneutica. Era peraltro interessante leggere curiosità e sorpresa nei visi dei miei studenti nello scoprire che tale domanda affondava le sue radici nella storia antica e non nel mondo contemporaneo. P er ragionare sul valore corrente di un’attività, la Scrittura prende in esame il pricing di un campo, trattandosi di un importante asset reale per le epoche redazionali dei testi biblici. Il primo riferimento al prezzo di un campo si trova in Genesi 23,9, ovvero nella complessa negoziazione compiuta da Abramo con Efrom l’Ittita, per dare a Sara una sepoltura. Si tratta di una transazione sui generis, motivata dalla pietas e non da motivazioni economiche. E infatti, in questo caso, l’elevato prezzo della transazione sul campo assume un rilievo segnaletico importante. Tuttavia, la spiegazione più organica su questo tema si trova nei tre sopracitati versetti del Levitico, di cui fornirò una mia traduzione. I tre versetti si collocano nel contesto del Giubileo, che contemplava, almeno teoricamente, dopo sette settimane di anni (49 anni), la riallocazione complessiva della Terra al proprietario originario. La prospettiva della riallocazione della Terra al proprietario iniziale ha due diverse motivazioni. La prima, di carattere ideale, trova le sue radici nel concetto di destinazione universale dei beni. La Terra appartiene a Dio ed è affidata all’uomo in qualità di “amministratore pro tempore”. Dopo un certo periodo di tempo è pertanto necessario che la Terra torni al legittimo proprietario. La consapevolezza di non essere il proprietario dei beni, ma un fiduciario, modifica l’atteggiamento e la propensione dell’uomo verso i beni. I n secondo luogo, da un punto di vista storico il tema della restituzione dei beni emerge dopo il ritorno dall’esilio di Babilonia, come possibile risposta alla definizione dei rapporti fra gli esuli che tornavano e la parte del popolo che era rimasta nella terra d’origine, ovvero fra esuli e rimanenti. La cattività babilonese era stata infatti molto diversa rispetto alle deportazioni di massa che fecero gli Assiri, quando nel 721 a.C. abbatterono il Regno di Israele e insidiarono il Regno di Giuda con l’assedio di Sennacherib a Gerusalemme nel 701 a.C. Diversamente i Babilonesi, dopo la presa di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor nel 586 a.C. e la fine del Regno di Giuda, si limitarono a deportare alcune migliaia di persone che componevano, tuttavia, la classe dirigente e l’élite culturale del Regno di Giuda. U n tema simile si è posto in tempi più vicini a noi, dopo la caduta del Muro di Berlino. Nel 1945, infatti, sotto l’incalzare dell’Armata Rossa milioni di tedeschi si riversarono nella parte occidentale della Germania. Al momento della riunificazione, mezzo secolo più tardi, si pose il problema della composizione di interessi anche economici e patrimoniali fra chi era scappato verso Occidente e chi era rimasto in quella ch sarebbe diventata la Repubblica Democratica Tedesca. N ei versetti del Levitico vengono fornite alcune indicazioni per ottenere il prezzo di equilibrio di un’attività reale che possono essere ragionevolmente estese anche ad altre attività reali o finanziarie. È interessante notare che questo argomento venga affrontato nel Codice di Santità, ovvero nel contesto di uno dei tre Codici presenti nella Torah ebraica. L evitico 25, 14 recita: « E quando vendi una vendita al tuo vicino o acquistate qualcosa dal vostro vicino, non maltratti un uomo suo fratello». La determinazione del prezzo del campo si colloca, in primo luogo, nel contesto di “non maltrattamento” nei confronti del vicino. Costui rappresenta il proximus e non un agente senza nome presente sul mercato. L’idea del proximus nel mondo antico risulta molto diversa da quella del “vicino di casa” di un condominio contemporaneo, di cui magari si ignora anche il nome. P er rendere l’idea di chi fosse il proximus nell’antichità possiamo immaginare i cittadini della stessa “polis” che combattono fianco a fianco, scudo a scudo nella linea degli opliti. Se non ci fosse stata una perfetta fiducia nel proximus a Maratona, la fanteria di linea oplitica degli Ateniesi e dei Platesi non avrebbe retto l’urto dei Persiani. Il tema del prezzo del campo è pertanto, in primo luogo, un fatto relazionale, un fatto di civiltà e di giustizia.
L a ricerca di un prezzo di equilibrio nel contesto di una transazione economica relativa a un campo deve perseguire quindi in primo luogo l’obiettivo che “nessuno faccia torto al proprio fratello”, ovvero nel linguaggio economico corrente di non incorrere in un fallimento di mercato che determina un prezzo non di equilibrio e quindi senza significato economico. I l successivo versetto 25, 15 recita: «Secondo il numero degli anni dopo il Giubileo comprerai dal tuo vicino egli venderà a te quello che viene fuori (dal campo) in proporzione al numero degli anni ». Il versetto trova la sua spiegazione e il suo commento nel successivo versetto 25, 16 che recita: «Secondo la moltitudine degli anni (in base alla moltitudine degli anni) accrescerai il (suo) prezzo (d’acquisto) e nel loro essere pochi gli anni, renderai poco (diminuirai) il prezzo perché egli un numero di quello che viene fuori ti vende». I l prezzo dell’attività finanziaria, pertanto, non è altro che la somma dei prodotti ottenuti dal campo, ovvero la somma dei raccolti fisici o dei proventi finanziari. Siccome il Giubileo rappresenterebbe il momento in cui il campo torna al proprietario originale, il rapporto fra prezzo del campo e raccolto varia a seconda della distanza temporale dal Giubileo.
S e il testo biblico contempla il valore di un’attività come la somma dei proventi ricavabili dalla stessa, il testo non menziona che tale somma dei raccolti deve essere scontata. Tale omissione è del tutto compatibile con l’assenza di crescita nel contesto dell’economia del Medio Oriente di circa 2.500 anni fa, probabile momento redazionale del testo (Liverani 2004). N ella determinazione del pricing di un’attività finanziaria, il testo biblico pone in primo luogo un tema sostanziale di giustizia nel contesto complessivo della transazione. È una giustizia che va ben oltre l’equità o la fairness a cui siamo abituati. E questa idea di “giustizia sostanziale” è la grande eredità che ci consegna il testo biblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Al momento della riunificazione tedesca si ebbero problemi patrimoniali simili a quelli che vennero affrontati dopo la cattività babilonese con il ritorno degli esuli